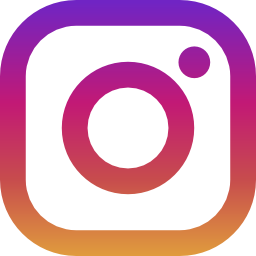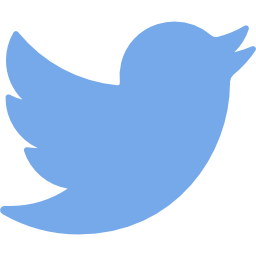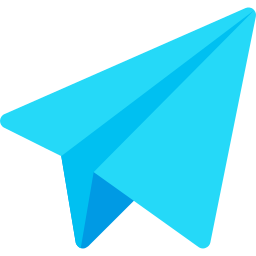di Alessandra Carenzio
Abbiamo seguito la presentazione del Rapporto How’s Life for Children in the Digital Age?, evento promosso dall’OECD.
Il rapporto, leggiamo nel sito (https://www.oecd.org/en/publications/how-s-life-for-children-in-the-digital-age_0854b900-en.html),
“offre una panoramica dello stato attuale della vita dei bambini nell’ambiente digitale nei Paesi OCSE, basandosi sui più recenti dati comparativi internazionali. Esamina le sfide legate al garantire che i bambini siano al tempo stesso protetti e in grado di utilizzare i media digitali in modo vantaggioso, gestendo i potenziali rischi”.
La logica alla base del Rapporto ricorda l’importanza di azioni di rete, con diversi soggetti, che richiedono
“un approccio politico che coinvolga l’intera società e diversi settori, includendo fornitori di servizi digitali, professionisti della salute, educatori, esperti, genitori e bambini stessi, al fine di proteggerli, responsabilizzarli e sostenerli, affrontando al contempo le vulnerabilità che si manifestano anche offline, con l’obiettivo finale di migliorare il loro benessere e i risultati futuri”.
Un punto interessante emerso durante la presentazione: dobbiamo pensare ai luoghi che “concediamo” ai bambini e alle bambine oggi (ma anche agli e alle adolescenti, forse in particolare ai ragazzi e alle ragazze). Spesso si tratta di spazi inadeguati che non portano infanzia e adolescenza a muoversi, a vivere, a esprimersi adeguatamente.
Aspetto che porta alla scelta di device non come alleati in “alternanza”, seguendo Tisseron, ma come scelta univoca.
Dobbiamo creare questi spazi, pensiamo ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, per costruire una società “con” e non solo “per” l’infanzia e l’adolescenza. Per intenderci, se vogliamo migliorare la vita “on screen”, dobbiamo migliorare la vita in generale, le occasioni, le proposte, la bellezza dello stare insieme. Altrimenti è facile, senza impegnarsi, puntare il dito contro gli schermi.
Nel corso della mattina abbiamo potuto vedere un bellissimo documentario di Gilles Vernet Et si on levait les yeux? Une classe face aux écrans, che ha coinvolto una classe francese della scuola primaria, un momento di grande valore per le discussioni attivate, le proposte, le parole. Il titolo, tradotto, suona così: E se alzassimo lo sguardo? Una classe davanti agli schermi.
Si tratta di “un’esperienza unica condotta da un maestro-regista e dalla sua classe di CM2 (quinta elementare). Per un anno intero, Gilles Vernet dialoga con i suoi alunni, i loro genitori e alcuni esperti sul ruolo degli schermi nella nostra società”.
Sul sito del progetto si legge:
“Questo documentario di 52 minuti immerge lo spettatore in una realtà coinvolgente, in cui si riflette sul senso della vita. Affronta i pericoli dell’eccessiva esposizione degli schermi nei confronti dei bambini, senza eludere le responsabilità di ciascuno, inclusi i genitori. È anche un film che sfiora la felicità, il desiderio di vivere insieme e in cui si respira. Si tratta di una questione di salute pubblica e democratica, affrontata in modo originale, toccante e autentico”.
Gilles Vernet è intervenuto anche nel corso della presentazione, testimoniando l’importanza di confrontarsi in classe, di riconoscere e confrontarsi con il linguaggio dei più giovani, con le loro esigenze spesso inespresse, perché faticose.
Per approfondire si rimanda al sito del progetto: https://etsionlevaitlesyeux.com/, ricordando che il film è anche un libro e un podcast.
Il tema non si chiude né con un Rapporto, né con un video. Per aumentarne l’efficacia occorre, come detto, adottare un approccio globale che coinvolga l’intera società e tutti i livelli con un’azione coordinata tra i principali attori coinvolti, inclusi governi, fornitori di servizi, educatori e famiglie.
Proprio a partire dal Capitolo 5 del Rapporto, emergono quattro pilastri fondamentali, che riportiamo in forma integrale rimandando al sito e al Rapporto per una lettura completa:
- “L’istituzione di quadri normativi efficaci e la promozione dello sviluppo di tecnologie e servizi che pongano la sicurezza dei bambini al primo posto”.
- “Il potenziamento dell’alfabetizzazione e delle competenze digitali dei bambini, con scuole e insegnanti che svolgono un ruolo cruciale nel renderli più consapevoli e autonomi”.
- “Il supporto a genitori e caregiver attraverso linee guida che li aiutino a orientarsi tra opportunità e rischi legati all’uso del digitale da parte dei bambini”.
- “L’inclusione dei punti di vista e delle esperienze dei bambini nella progettazione delle politiche, affinché i loro bisogni siano compresi in modo accurato e le misure di supporto siano attuate in modo efficace”.
Le restrizioni non funzionano da sole, conclude Andrew Przybylski, “dobbiamo prendere la cosa seriamente” (qui per conoscere il profilo e le pubblicazioni del professore, che insegna Human Behaviour and Technology ll’Università di Oxford – https://www.przybylski.xyz/).
Aggiungiamo anche, come detto da Noa López Fernández – studentessa di Computer Engineering alla Universidad Carlos III de Madrid invitata a partecipare alla sessione – occorre accompagnare i genitori e le persone attorno ai bambini e alle bambine, mentre incolparli e stigmatizzarli non serve a molto, se non a creare barriere e paure ulteriori.
Rimandiamo alle risorse indicate e al Rapporto (da cui è tratta l’immagine che apre l’articolo): OECD (2025), How’s Life for Children in the Digital Age?, OECD Publishing, Paris.