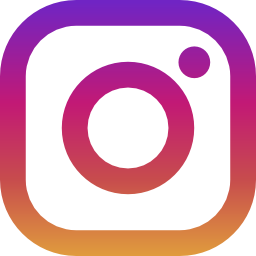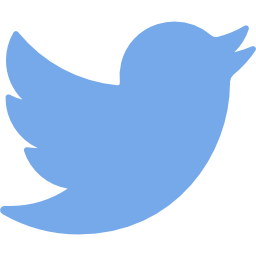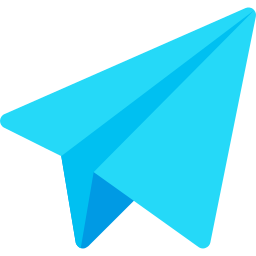Di Matteo Mancini
Un ippopotamo robotico fluttua nel cielo. Un coccodrillo-jet bombarda un deserto digitale. E milioni di adolescenti guardano, condividono, imitano.
È l’Italian Brain Rot, la tendenza virale che ha ridefinito l’estetica memetica del 2025. Creato con l’ausilio dell’AI generativa, questo fenomeno fonde immagini surreali, filastrocche dissociate, narrazioni grottesche e humor distorto. Una forma estrema di contenuto virale senza scopo, che si espande su TikTok, Instagram e YouTube, ipnotizzando il feed globale.
Il termine “brain rot” – marciume cerebrale – era già diffuso tra Gen Z e Alpha per indicare contenuti tossici, low-effort ma irresistibili.
In Italia, e non solo, si è evoluto in una forma culturale a sé, popolata da personaggi come:
• Tralalero Tralalà – squalo antropomorfo con scarpe Nike;
• Ballerina Cappuccina – metà danzatrice, metà tazzina;
• Tung Tung Tung Sahur – creatura totemica armata di mazza;
• Bombardiro Crocodilo – jet militare con testa di coccodrillo.
La forza dell’Italian Brain Rot non è narrativa, ma ritmica e visiva. È ipnotico, come una ninna nanna per la mente distratta. I contenuti non si capiscono: si subiscono, si assorbono. Non si pensa, si scorre. Trallalero trallallà.
Siamo di fronte a una forma di ipnosi cognitiva: una risposta automatica allo stimolo, non tanto per ciò che viene detto, ma per come viene detto. È il ritmo, il tono, la ripetizione, l’eccesso visivo che cattura. Il “successo” non è dovuto alla comprensibilità, ma alla capacità di sospendere il senso. Proprio nel nonsense, i giovani trovano un territorio neutro, “uno spazio dove non è richiesto nulla: né prestazione, né identità, né messaggi morali” (Han, 2010).
Il termine “brain rot”, registrato tra i neologismi da Treccani, indica una condizione di sovraccarico mentale causata dalla fruizione prolungata e passiva di contenuti digitali senza valore cognitivo, tipicamente su piattaforme come TikTok e YouTube. A rendere così penetrante il fenomeno dell’Italian Brain Rot non è solo l’assurdità dei contenuti, ma il modo in cui l’intelligenza artificiale li produce e l’algoritmo li ripropone.
Non siamo di fronte a video isolati o virali “per caso”: siamo dentro una filiera automatica della ripetizione, in cui la macchina:
• genera personaggi, ambienti, nomi e filastrocche combinando elementi esistenti in modi sempre nuovi;
• seleziona quelli più “engaging” (a livello emotivo, visivo o disturbante);
• li rilancia nel feed degli utenti con variazioni minime, creando un effetto di déjà vu programmato.
È qui che la ricombinazione diventa ipnosi: ogni video sembra nuovo ma è sempre uguale, ogni personaggio è diverso ma familiare, ogni nonsense è riconoscibile. L’utente – in particolare in età adolescenziale – non viene stimolato, ma avvolto, trattenuto in un loop di contenuti che si somigliano, si rincorrono, si autoalimentano.
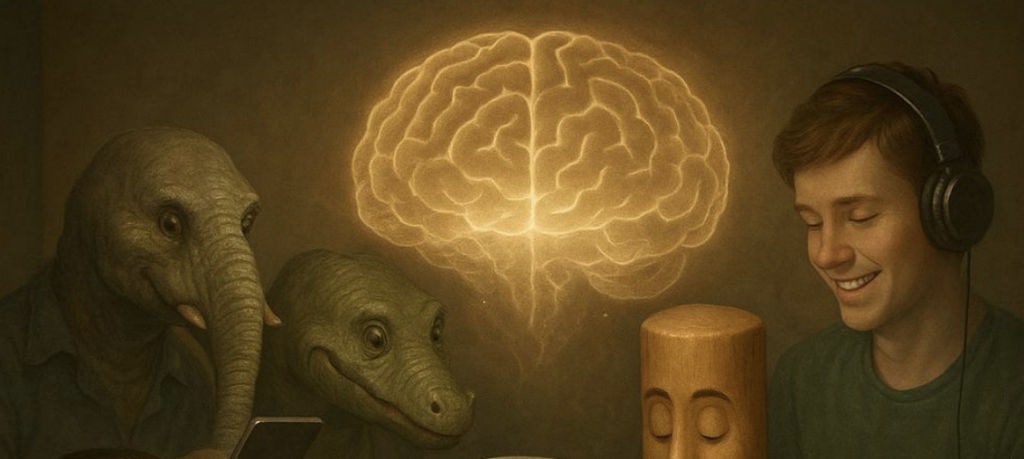
La AI non inventa: ricompone. L’algoritmo non insegna: trattiene.
Questo meccanismo ha una potenza memetica e semiotica enorme: crea un’estetica della ripetizione che si finge caos, ma è profondamente calcolata. I contenuti appaiono casuali, grotteschi, bizzarri.
In questa dinamica, l’AI non è solo uno strumento creativo, ma una macchina culturale: un motore automatico di produzione simbolica che agisce nel profondo della percezione, dell’abitudine visiva,
della soglia d’attenzione.
Molti dei personaggi del Brain Rot operano sul crinale del black humor. Prendiamo Tung Tung: con il nome ispirato alla tradizione islamica del richiamo al pasto del Ramadan, viene presentato come una figura mostruosa, armata e rituale. È una parodia ambigua: sacra e grottesca,
folklorica e disturbante.
Più esplicito è Bombardiro Crocodilo: un ibrido tra aereo da guerra e rettile antropomorfo, impegnato in azioni belliche surreali ma con riferimenti a conflitti reali, come Gaza o la Palestina. È humor nero, cupo, scomodo. Ma anche, forse, una forma distorta di elaborazione collettiva del trauma: prendere ciò che fa paura e trasformarlo in una caricatura assurda con un tono post-satirico, non filtrato, non educativo.
È qui che si apre la domanda educativa: che cosa stanno davvero cercando, dentro tutto questo delirio, le ragazze e i ragazzi che ne fanno uso? Ridono davvero, o stanno cercando un modo per non dover sentire?
L’Italian Brain Rot, nella sua assurdità, ci mette davanti a un compito non tecnico, ma umano: non lasciare soli gli adolescenti nel nonsense. La loro fascinazione per l’assurdo, per il grottesco, per l’incongruo, non è semplice idiozia collettiva. “È spesso una richiesta implicita di ascolto, di sospensione del giudizio, di uno spazio in cui essere attraversati da confusione, ironia, rabbia e desiderio”.
Non serve spiegare a un adolescente che Bombardiro Crocodilo è assurdo. Lo sa già. Ma se lo guarda in loop, se lo ripete, se ne fa icona – è lì che comincia il compito educativo.
“Educare, in questo contesto, non significa fornire spiegazioni, ma restare accanto”, creare contesti di parola e ascolto dove anche il nonsense possa essere raccontato. Dove anche l’umorismo più nero possa trovare uno spazio per essere accolto e compreso.
Riferimenti:
Disa, F. (2025, 18 aprile). L’estetica memetica del brainrot italiano. L’Indiscreto. https://www.indiscreto.org/lestetica-memetica-del-brainrot-italiano/
Eco, U. (1990). I limiti dell’interpretazione. Milano: Bompiani.
Han, B.-C. (2010). La società della stanchezza. Roma: Nottetempo (trad. E. Baccarini).
Morin, E. (1999). La testa ben fatta: Riforma dell’insegnamento e riforma del pensiero. Milano: Raffaello Cortina.
Polidoro, D. (2025, 18 aprile). Tutti i personaggi dei brain rot italiani, che ora spopolano e si stanno trasformando nei Pokémon di Internet. Wired Italia. https://www.wired.it/gallery/brain-rotitaliani-personaggi-nomi-spiegazione-storia-foto/
Servidio, G. (2025, 16 maggio). L’Italian Brain Rot è il trend di meme nonsense che sta spopolando sul Web: cos’è e perché ha successo. Geopop. https://www.geopop.it/italian-brain-rot-trend-memenonsense-sul-web-cose-perche-successo/
Treccani (2024). Neo-brain rot. https://www.treccani.it/vocabolario/neo-brainrot_(Neologismi)/
Turkle, S. (2011). Alone together: Why we expect more from technology and less from each other. New York, NY:
Basic Books.